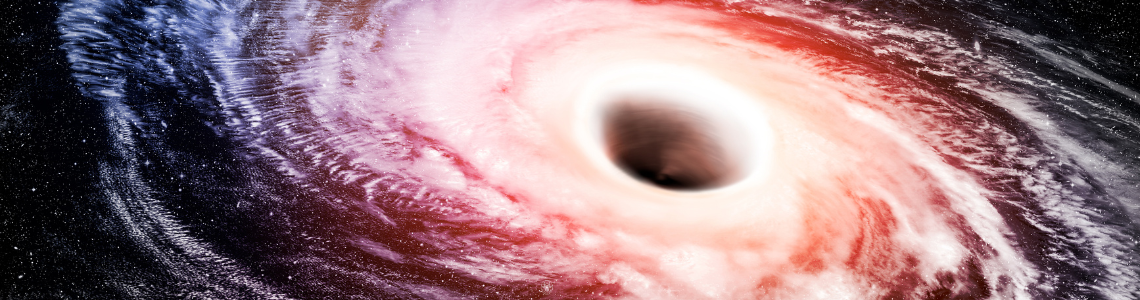
Intervista a Raffaella Schneider sull’osservazione di uno dei più antichi buchi neri supermassicci
Un team internazionale di scienziati ha recentemente fatto una scoperta straordinaria: un buco nero supermassiccio "dormiente", risalente a meno di 800 milioni di anni dopo il Big Bang, osservato grazie ai dati del telescopio spaziale James Webb. Questo buco nero, che ha una massa pari a 400 milioni di volte quella del Sole, rappresenta una novità nel campo dell'astrofisica, poiché è il primo buco nero supermassiccio non attivo mai osservato durante l'epoca della reionizzazione. La ricerca, alla quale ha partecipato anche la Prof.ssa Raffaella Schneider, docente di Astrofisica del Dipartimento di Fisica della Sapienza e fellow SSAS, apre nuovi scenari nello studio della formazione dei buchi neri e delle galassie primordiali. ed è stata pubblicata su Nature. In questa intervista, la prof.ssa Schneider ci spiega l'importanza di questa scoperta e ci aggiorna sullo stato dell’arte della ricerca sui buchi neri.
1. Qual è l'importanza di studiare i buchi neri supermassicci e la loro connessione con le galassie?
Sappiamo, grazie alle osservazioni delle galassie vicine, che tutte le galassie hanno al loro centro un buco nero supermassiccio. Di solito, la massa di questi buchi neri rappresenta circa lo 0,1% della massa totale delle stelle della galassia che li ospita. La relazione costante tra la massa del buco nero supermassiccio e quella delle stelle nella galassia suggerisce una connessione tra la crescita del buco nero e quella della galassia. È probabile che i due crescano insieme o che le loro evoluzioni siano correlate. Studiare questa dinamica ci permette di comprendere meglio l'origine delle galassie e dei buchi neri supermassicci che osserviamo oggi.
2. Quali progressi sono stati fatti nella ricerca sui buchi neri supermassicci grazie al telescopio spaziale James Webb?
Negli ultimi due anni, la ricerca sui buchi neri supermassicci ha fatto enormi progressi grazie al telescopio spaziale James Webb. Questo telescopio, in orbita da tre anni, offre capacità osservative straordinarie in termini di sensibilità e risoluzione, permettendoci di osservare sorgenti più deboli e distanti che mai prima. Una delle scoperte più significative è che i buchi neri nucleari nelle galassie antiche sono più massicci, in proporzione, rispetto a quelli nelle galassie attuali. Questo suggerisce che i buchi neri supermassicci crescessero più velocemente delle loro galassie ospiti nelle prime fasi evolutive. Una possibile spiegazione proposta dal mio gruppo di ricerca è che questi buchi neri crescessero accrescendo gas in modo "super-critico", cioè a un tasso superiore al limite teorico, ma solo per brevi periodi di tempo.
3. Quali nuove scoperte sono emerse riguardo alla crescita dei buchi neri supermassicci?
Durante le osservazioni pubblicate su Nature, abbiamo identificato un buco nero "over-massive" con una massa pari al 10% di quella della sua galassia ospite, un valore enormemente superiore allo 0,1% tipico nell'universo locale. Questo suggerisce che i buchi neri supermassicci nelle galassie antiche crescessero molto più rapidamente rispetto alla loro galassia. La crescita dei buchi neri non segue un percorso lineare: avviene in fasi brevi e intense di accrescimento "super-critico", con tassi superiori al limite teorico, consentendo al buco nero di raggiungere rapidamente grandi masse. Queste fasi durano solo circa un milione di anni, una frazione minima rispetto alla vita delle galassie.
4. Perché alcuni buchi neri supermassicci sono descritti come "dormienti"?
Alcuni buchi neri appaiono "dormienti", ossia non stanno attualmente accrescendo massa in modo significativo. Questo fenomeno può essere spiegato dal loro meccanismo di crescita episodico: il buco nero attraversa brevi periodi intensi di accrescimento alternati a lunghe fasi quiescenti, durante le quali non cresce significativamente. Questo modello di crescita episodica suggerisce che il comportamento dei buchi neri supermassicci possa essere più complesso di quanto precedentemente ipotizzato.
5. Qual è l'importanza della scoperta e cosa sappiamo sui buchi neri supermassicci?
Questa scoperta ci aiuta a chiarire l'importanza del nostro lavoro. Sappiamo che i buchi neri crescono insieme alle galassie e l'ipotesi che abbiamo formulato è che si formino a partire da buchi neri di massa molto più piccola, fino a qualche centinaio di masse solari. Questi buchi neri "seme" (seed black holes) si formano in un universo molto antico, praticamente contemporaneamente alle prime popolazioni stellari. Una volta formati, per diventare supermassicci e raggiungere masse che vanno da 10^6 a 10^10 volte quella del Sole, devono crescere accumulando enormi quantità di gas. Se la crescita è continua, diventa più difficile osservare questi buchi neri in fase quiescente, poiché per raggiungere masse così grandi è necessario accumulare enormi quantità di gas.
6. I buchi neri sono fonte di ispirazione per la cultura pop: cosa c’è di vero tra viaggi nel tempo e salti interdimensionali?
Il mio film preferito che ha come protagonista un buco nero è sicuramente Interstellar. A quel film ha contribuito moltissimo uno dei più grandi esperti di buchi neri al mondo, Kip Thorne, premio Nobel per la fisica per la scoperta delle onde gravitazionali. Thorne ha scritto la prima versione della sceneggiatura del film e un bellissimo libro intitolato La scienza di Interstellar, dove spiega cosa c’è di vero, cosa è ragionevolmente plausibile e cosa invece è puramente speculativo nella trama.
Le immagini del buco nero Gargantua, protagonista di Interstellar, sono state ottenute lavorando graficamente su una simulazione numerica. Questa simulazione integra le equazioni di Einstein della relatività generale, che descrivono come lo spazio e il tempo si deformano intorno a un buco nero. Quindi, la base scientifica delle immagini è estremamente accurata. Naturalmente, c'è stato un lavoro di grafica per adattare il risultato alla realtà cinematografica, ma lo stesso Kip Thorne ha dichiarato di essere rimasto profondamente colpito quando ha visto i primi rendering di come lo spazio si deforma intorno a Gargantua.
Il lavoro svolto è stato straordinario e dimostra come, sempre di più, film di alta qualità si basino sulle conoscenze scientifiche attuali per rappresentare fenomeni complessi come i buchi neri. Tuttavia, c’è sempre una parte di speculazione che la ricerca scientifica attuale non è ancora in grado di confermare.
______________________________________________________________________
Lo studio pubblicato su Nature dal titolo “A dormant overmassive black hole in the early Universe” è il frutto della collaborazione di diversi studiosi e ricercatori: Ignas Juodžbalis, Roberto Maiolino, William M. Baker, Sandro Tacchella, Jan Scholtz, Francesco D’Eugenio, Joris Witstok, Raffaella Schneider, Alessandro Trinca, Rosa Valiante, Christa DeCoursey, Mirko Curti, Stefano Carniani, Jacopo Chevallard, Anna de Graaff, Santiago Arribas, Jake S. Bennett, Martin A. Bourne, Andrew J. Bunker, Stéphane Charlot, Brian Jiang, Sophie Koudmani, Michele Perna, Brant Robertson, Debora Sijacki, Hannah Übler, Christina C. Williams & Chris Willott.

